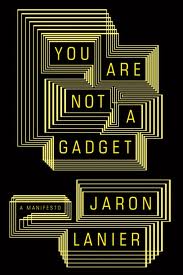Qualcosa è cominciato ad andare storto nella rivoluzione digitale intorno al passaggio del millennio. Il World Wide Web è stato inondato da una fiumana di tecnologie di pessimo livello talvolta etichettate come Web 2.0. Questa ideologia promuove una libertà radicale, ma paradossalmente si tratta di una libertà riservata più alle macchine che alle persone. Eppure se ne sente parlare come di «cultura open».
Commenti anonimi sui blog, video vacui che cercano di essere spiritosi e mash-up dilettanteschi: cose che possono sembrare solo banali e inoffensive, ma che nel loro insieme, in quanto pratica diffusa di comunicazione frammentaria e impersonale, hanno depauperato l'interazione fra le persone.
La comunicazione, oggi, viene spesso esperita come un fenomeno superumano, torreggiante sopra i singoli. Una nuova generazione ha raggiunto la maggiore età con aspettative ridotte riguardo a quello che una persona può essere, e riguardo a chi ogni persona possa diventare.
Quando lavoro su gadget digitali sperimentali in laboratorio, per esempio su variazioni inedite di realtà virtuale, mi torna sempre in mente come piccole modifiche nei dettagli di un progetto digitale possano avere effetti profondi e imprevisti sull'esperienza degli esseri umani che vi giocano. La più lieve delle modifiche in una cosa in apparenza insignificante come la semplicità d'uso di un pulsante può talvolta alterare completamente alcuni modelli di comportamento.
Per esempio, il ricercatore Jeremy Bailenson della Stanford University ha dimostrato che, modificando la statura dell'avatar di una persona in ambiente di realtà virtuale immersiva, si migliorano l'autostima e la percezione sociale di sé. Le tecnologie sono estensioni del nostro io e, come gli avatar nel laboratorio di Jeremy, il minimo dettaglio di un gadget può alterare la nostra identità. È impossibile lavorare con la tecnologia dell'informazione senza occuparsi nello stesso tempo di ingegneria sociale.
Ci si potrebbe domandare: «Se dedico molto tempo ai blog, a Twitter e Wiki, in che modo ciò modifica quello che sono?», oppure: «Se la "mente alveare" è il mio pubblico, chi sono io?». Noi, inventori di tecnologie digitali, siamo come protagonisti di un monologo o neurochirurghi, in quanto il nostro lavoro ha a che fare con profonde questioni filosofiche; purtroppo, di recente ci siamo dimostrati filosofi scadenti. Quando gli sviluppatori di tecnologie digitali progettano un programma che vi richiede di interagire con un computer come se fosse una persona, vi stanno chiedendo di accettare, in un angolo riposto del cervello, che a vostra volta potreste essere considerati come se foste un programma. Quando progettano un servizio internet il cui editing è affidato a un'immensa folla anonima, lasciano intendere che un assembramento casuale di esseri umani sia un organismo dotato di un legittimo punto di vista.
Diversi modelli di media stimolano potenzialità diverse nella natura umana. Non dovremmo cercare di rendere il più efficiente possibile la mentalità di branco. Dovremmo, piuttosto, cercare di instillare il fenomeno dell'intelligenza individuale.
«Che cos'è una persona?». Se conoscessi la risposta, sarei in grado di programmare una persona artificiale all'interno di un computer. Ma non la conosco. Essere una persona non si esaurisce in una formula qualunque, è una ricerca, un mistero, un atto di fede.
Sarebbe dura per chiunque, figuriamoci per un tecnologo, alzarsi al mattino senza nessuna fiducia nel fatto che il futuro può essere migliore del passato.
Negli anni Ottanta, quando internet era disponibile solo per un ristretto numero di pionieri, mi trovavo spesso di fronte gente spaventata all'idea che le strane tecnologie su cui lavoravo, come la realtà virtuale, potessero scatenare i demoni della natura umana. Le persone, per esempio, non sarebbero diventate dipendenti dalla realtà virtuale come da una droga? Non vi si sarebbero lasciate intrappolare, incapaci di tornare nel mondo fisico dove viviamo tutti noialtri? Alcune di queste domande erano insulse, altre profetiche.
In quegli anni facevo parte di un'allegra banda di idealisti. Se negli anni Ottanta foste venuti a pranzo, per dire, con me e John Perry Barlow, poi cofondatore della Electronic Frontier Foundation, o Kevin Kelly, che avrebbe creato e diretto la rivista «Wired», erano queste le idee di cui ci avreste sentiti discutere. Gli ideali sono importanti nel mondo della tecnologia, ma il meccanismo tramite cui gli ideali influenzano gli eventi qui è diverso che in altri ambiti della realtà. I tecnologi non sanno essere persuasivi nell'esercizio della loro influenza, quantomeno non abbastanza. La categoria annovera alcuni comunicatori di vaglia (come Steve Jobs), ma in genere è assai poco affascinante.
Noi tecnologi escogitiamo estensioni per il vostro essere: occhi e orecchie remoti (webcam e telefoni cellulari) ed espansioni di memoria (il mondo di dettagli ricercabile online). Queste estensioni diventano le strutture mediante le quali vi connettete al mondo e alle altre persone. Queste strutture, a loro volta, possono cambiare il modo in cui concepite voi stessi e il mondo. Noi armeggiamo con la vostra filosofia manipolando direttamente la vostra esperienza cognitiva, non indirettamente tramite l'argomentazione. Basta un gruppo molto ristretto di ingegneri per creare tecnologia in grado di dar forma, con velocità incredibile, all'intero futuro dell'esperienza umana. Pertanto, prima che tali manipolazioni dirette vengano progettate, fra sviluppatori e utenti dovrebbero aver luogo dibattiti di portata cruciale sulla relazione degli esseri umani con la tecnologia.